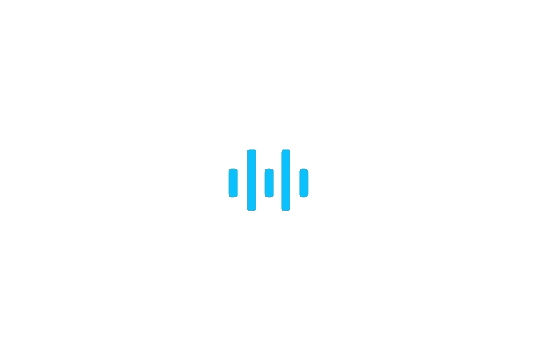
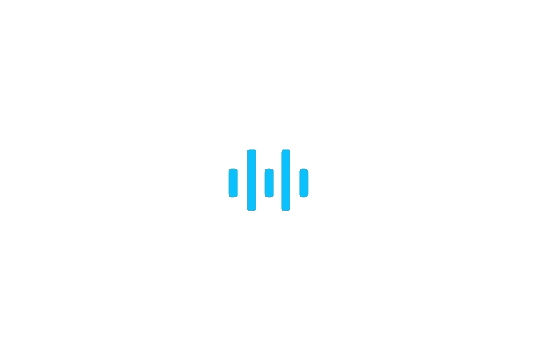
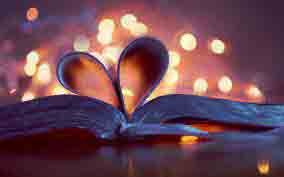

Nel mondo latino è diverso il contesto, sociale e culturale, e diversa è la visione dell’amore. Roma è il centro del mondo, e la religione cristiana interverrà a trasformare completamente la concezione della vita. Rimane in principio una visione di Venere (l’Afrodite greca) come personificazione sia dell’amore sia della fertilità, e come principale antidoto alle liti e alla guerra, poiché ritorna l’immagine di Marte che si placa solo nel suo grembo,1 e tuttavia l’immaginario e i valori inesorabilmente si trasformano, e l’attenzione si sposta altrove. Nella Roma imperiale il matrimonio è visto come condizione naturale dell’amore, poiché garantisce la procreazione e la continuazione della stirpe.2
Non siamo molto distanti per certi versi dal contesto attuale, in cui il modello sociale, culturale e di tradizioni, educa sempre a un desiderio: un buon matrimonio, felice, d’amore, stabile. Per quanto al giorno d’oggi si possa discutere dell’aspirazione al matrimonio, in quanto contratto legale in qualche modo pieno di “falle”, il modello percepito in questo momento storico è dell’aspirazione a un rapporto di coppia stabile, che sia amore assoluto, a supplenza delle certezze che mancano in tutti gli altri aspetti della vita, con la labilità del momento storico stesso. Ciò influenza naturalmente anche l’idea che possa esistere la metà complementare del proprio Io, come dicevamo poc’anzi del mito raccontato da Platone per bocca di Aristofane.
I poeti d’amore dell’epoca imperiale sono gli elegiaci, in cui ritroviamo la lirica amorosa di esaltazione e sofferenza introdotta da Catullo. Essi cantano proprio l’aspetto di questa sofferenza prolungata, di asservimento alla donna, la domina, capricciosa e infedele, che istiga la gelosia e non si concede facilmente. L’immagine ricorrente è quella di un poeta che deve inneggiare alla donna nonostante questa lo rifiuti. In questo panorama emerge Ovidio, perché innanzitutto era più interessato alla natura dell’amore e alla sua concretezza, piuttosto che alla moralità, e per l’attualità che caratterizza una sua opera in particolare, i Rimedi per l’amore.
Ovidio è uno degli ultimi grandi poeti dell’era classica, ma ha una produzione in profondo contrasto con l’epoca, poiché osserva senza pudori le due facce della stessa medaglia: da un lato una Roma colta e raffinata, imperniata sull’istituto del matrimonio, dall’altro la reazione ai costumi imposti dalla tradizione del mos maiorum, e perciò pratiche più libertine, anche se nascoste. Ha un atteggiamento ironico e a tratti beffardo, ben distante dall’idealismo di Platone di 400 anni prima. Nei due libri Amori e L’arte di amare, cerca di insegnare agli amanti come ottenere un’unione armoniosa, serena e che rechi piacere, senza che si instaurino rapporti di dipendenza, e di conseguenza profondo malessere per uno dei due partner. Alcuni di questi consigli sono ancora oggi perle di saggezza: evitare le critiche, lodare sempre il partner per le sue qualità migliori. Siamo in un’epoca in cui evidentemente l’amore è conflittuale, e risulta essere per molti una forza distruttiva.